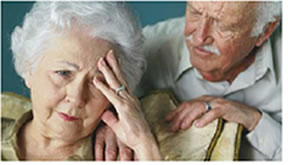I malati sono almeno il doppio se si considera quelli non diagnosticati. L’appello è sempre rivolto alla diagnosi precoce e alla prevenzione : una visita neurologica e test neurocognitivi alle prime avvisaglie sintomatologie. E i test genetici sui famigliari per la valutazione del rischio e per una vera prevenzione.
Sono 600.000 i malati di Alzheimer in Italia, ma a causa dell’invecchiamento della popolazione sono destinati ad aumentare. I costi diretti dell’assistenza ammontano a oltre 11 miliardi di euro, di cui il 73% a carico delle famiglie. Il costo medio annuo per paziente è pari a 70.587 euro, comprensivo dei costi a carico del Servizio sanitario nazionale, di quelli che ricadono direttamente sulle famiglie e dei costi indiretti (gli oneri di assistenza che pesano sui caregiver, i mancati redditi da lavoro dei pazienti, ecc.). È quanto emerge dalla terza ricerca realizzata dal Censis con l’Aima (Associazione italiana malattia di Alzheimer), con il contributo di Lilly, che ha analizzato l’evoluzione negli ultimi sedici anni della condizione dei malati e delle loro famiglie. L’età media dei malati di Alzheimer è di 78,8 anni (era di 77,8 anni nel 2006 e di 73,6 anni nel 1999).
Il 72% dei malati è costituito da pensionati (22 punti percentuali in più rispetto al 2006). E sono invecchiati anche i caregiver impegnati nella loro assistenza: hanno mediamente 59,2 anni (avevano 54,8 anni nel 2006 e 53,3 anni nel 1999). Il caregiver dedica al malato di Alzheimer mediamente 4,4 ore al giorno di assistenza diretta e 10,8 ore di sorveglianza. Il 40% dei caregiver, pur essendo in età lavorativa, non lavora e rispetto a dieci anni fa tra loro è triplicata la percentuale dei disoccupati (il 10% nel 2015, il 3,2% nel 2006). Il 59,1% dei caregiver occupati segnala invece cambiamenti nella vita lavorativa, soprattutto le assenze ripetute (37,2%). Le donne occupate indicano più frequentemente di aver richiesto il part-time (26,9%). L’impegno del caregiver determina conseguenze anche sul suo stato di salute, in particolare tra le donne: l’80,3% accusa stanchezza, il 63,2% non dorme a sufficienza, il 45,3% afferma di soffrire di depressione, il 26,1% si ammala spesso. Ad assistere i malati sono soprattutto figli e badanti. Pur essendo sempre i figli dei malati a prevalere tra i caregiver, in particolare per le pazienti femmine (in questo caso i figli sono il 64,2% dei caregiver), negli ultimi anni nell’assistenza al malato sono aumentati i partner (sono passati dal 25,2% del totale del 2006 al 37% del 2015), soprattutto se il malato è maschio. Questo dato spiega anche l’aumento della quota di malati che vivono in casa propria, in particolare se soli con il coniuge (sono il 34,3% nel 2015, erano il 22,9% del 2006) o soli con la badante (aumentati dal 12,7% al 17,7%). Nell’attività di cura del malato, i caregiver possono contare meno di un tempo sul supporto di altri familiari: nel 2015 vi fa affidamento il 48,6%, mentre nel 2006 era il 53,4%. La badante rimane una figura centrale dell’assistenza al malato di Alzheimer: ad essa fa ricorso complessivamente il 38% delle famiglie. La presenza di una badante ha un impatto significativo sulla disponibilità di tempo libero del caregiver. Se complessivamente il 47,8% dei caregiver segnala un aumento del tempo libero legato alla disponibilità di servizi e farmaci per l’Alzheimer, tra chi può contare sul supporto di una badante la percentuale cresce di oltre 20 punti percentuali (68,8%) e di circa 30 punti nel caso in cui il malato usufruisca della badante e di uno o più servizi (77,1%). Più consapevolezza sulla malattia, ma tempi lunghi per la diagnosi. Il 47,7% dei caregiver afferma di aver reagito subito alla comparsa dei primi sintomi della malattia del proprio assistito, interpellando il medico di medicina generale (47,2%), lo specialista pubblico (33,1%) o lo specialista privato (13,6%).
Solo il 6,1% si è rivolto immediatamente a una Uva (Unità di valutazione Alzheimer). Tuttavia, la gran parte degli intervistati dichiara di aver ricevuto la diagnosi da un professionista diverso da quello consultato per primo (63,1%). A formulare la diagnosi di Alzheimer è principalmente lo specialista pubblico (65,5%), in particolare un neurologo (nel 35,6% dei casi) o un geriatra (29,9%), e solo per il 13,4% è stato uno specialista privato. Nel tempo si è ridotta la percentuale di pazienti che hanno ricevuto la diagnosi da una Uva (dal 41,1% nel 2006 al 20,6% nel 2015), mentre è aumentata la quota di diagnosticati dallo specialista pubblico (era il 37,9% nel 2006, è il 65,5% oggi). Il tempo medio per arrivare a una diagnosi resta elevato, pur essendo diminuito da 2,5 anni nel 1999 a 1,8 anni nel 2015. Un’assistenza sempre più informale e privata. Diminuisce di 10 punti percentuali rispetto al 2006 il numero dei pazienti seguiti da una Uva o da un centro pubblico (56,6%). Quando la patologia è più grave il dato è ancora più basso (46%). Si abbassa leggermente anche la percentuale di pazienti che accedono ai farmaci specifici per l’Alzheimer: dal 59,9% al 56,1%. Ed è diminuito il ricorso a tutti i servizi per l’assistenza e la cura dei malati di Alzheimer: centri diurni (dal 24,9% al 12,5% dei malati), ricoveri in ospedale o in strutture riabilitative e assistenziali (dal 20,9% al 16,6%), assistenza domiciliare integrata e socio-assistenziale (dal 18,5% all’attuale 11,2%). «I tre studi realizzati da Censis e Aima negli ultimi sedici anni evidenziano come stia progressivamente cambiando il mondo dei malati di Alzheimer e delle loro famiglie», ha detto Ketty Vaccaro, responsabile dell’Area Welfare e Salute del Censis. «È un mondo che invecchia e cresce l’impatto della malattia in termini di isolamento sociale. La famiglia è ancora il fulcro dell’assistenza, ma può contare su una disponibilità di servizi che nel tempo si è ulteriormente ristretta, mentre sono ancora presenti le profonde differenziazioni territoriali dell’offerta»